Ogni labirinto (che sia dedalo di grotte naturali, cunicoli di catacombe o vie di una città) è sempre risolto, di per sé: nella sua struttura contiene già la sua soluzione. E’ la presenza di uno o più corpi al suo interno che attiva il labirinto, lo rende tale. Nel caso dei labirinti antichi, senza bivi, basta spendere una certa quantità di tempo per arrivare al suo centro e uscirne. Nei labirinti contemporanei, invece, a più scelte, entrano in gioco le decisioni di fronte ai bivi, la scelta, e su quali basi; dunque il libero arbitrio, e se esista; e non da ultima, necessariamente, la memoria: Un labirinto risolto diventa una certa quantità di informazione, immagazzinata nei ricordi, che ha il valore (commerciale) di sapere come si entra e si esce dal labirinto, a differenza di altri corpi che invece non ne sono a conoscenza.

Il Labirinto degli Specchi di Petřín (Praga). Fu costruito secondo il progetto dell’architetto Wiehl come padiglione del “Club dei turisti cechi“ (Klub českých turistů) in occasione della Mostra del Giubileo di Praga nel 1891.
A differenza del sapere nomade o contadino, che deriva dall’osservazione di un ordine naturale, quello nuovo e coltivato dentro la città è figlio di una struttura artificiale, dove chi detiene il “come se ne esce” spesso è la stessa persona che ha costruito il labirinto, o in parallelo: chi possiede la “soluzione” al labirinto burocratico della città è anche chi l’ha costruita, la città, ne ha deciso i quartieri, la collocazione dei corpi in base a criteri aprioristici.

“Labyrinth” di Jim Henson, 1986. Finché partecipa al gioco del labirinto (la Città dei Goblin), la protagonista vi è irrimediabilmente intrappolata, sia nei suoi corridoi che mutano continuamente, sia nelle sue regole irrazionali. Quando si rende conto che il Re dei Goblin non ha altro potere su di lei che quello che lei stessa gli concede, inconsapevolmente, la realtà stessa in un attimo va in frantumi, il labirinto cade a pezzi, e lei è libera di tornare a casa.

“Tra le mura di Eryx”, H.P.Lovecraft, prima edizione, 1939. Un labirinto invisibile, costruito da uomini lucertola che la razza umana sottovaluta, diventa la trappola mortale per coloro che vogliono impadronirsi dei loro cristalli.

“The cube”, Vincenzo Natali, 1997. La natura incomprensibile della struttura labirintica all’interno della quale i personaggi del film sono intrappolati (e da cui vengono uccisi) si rivela poi essere un modello matematico: i settori sono numerati con potenze di numeri primi; i singoli settori non sono fissi ma si spostano secondo permutazioni, seguendo un moto periodico. Soltanto l’enfant savant del gruppo, secondo il topos narrativo dell’inutile che si rivela poi essere la soluzione al problema, riesce a calcolare matematicamente in quali settori spostarsi per raggiungere l’uscita.

“Il labirinto del Fauno”, Guillermo del Toro, 2006.
Che il labirinto sia organico (il ventre della balena per Pinocchio, il ventre della madre da cui si cade al mondo) oppure inorganico (la catacomba come rifugio per i cristiani in età romana, le grotte naturali da esplorare per la speleologia), è interessante il concetto del labirinto – miniera. Secondo Jan Pieper, “labyrs” in quanto ascia bipenne e come derivazione dall’indoeuropeo “laura”, cava o miniera, condividono il concetto iniziale di strada pavimentata con rocce estratte artificialmente (altra caratteristica del palazzo di Cnosso inedita rispetto ai villaggi su terra battuta). Quindi, il legame con la miniera: come luogo di estrazione, e poi una volta esaurita come luogo di stoccaggio.
Se in età antica il sottosuolo era il regno delle divinità ctonie, oggi è la soluzione (dove vorremmo che si sciogliesse, soluzione in senso chimico) all’immagazzinamento di armi, oppure di scorie tossiche o radioattive. Prima è scavo, per estrarre materiale utile a costruire la città, in superficie; poi è vuoto da riempire, da rendere proficuo, utile, stoccando lì ciò che è stato prodotto (ed è inutilizzato, è scoria) dalla città. Nel primo caso, i corpi sono quelli dei minatori, che attraversano strati geologici alla scoperta di ciò che sta sotto; nel secondo caso, i corpi sono altrove, devono essere protetti da ciò che essi stessi hanno prodotto, e che troverà nascondimento nella miniera.

“The shining”, Stanley Kubrik, 1980.

“Tron”, Steven Lisberger, 1982.

Gioco da tavolo “Labirinto magico”, Ravensburger, 1986.
La caverna, la grotta, il sottosuolo come luoghi labirintici di “discesa agli inferi” dei corpi attraversa tutta la storia dell’umanità. In epoca antica e occidentale abbiamo Ulisse, Enea, Eracle, Psiche… ma si dà anche, in mitologia, una discesa a causa della perdita di un corpo amato: Enkidu, Persefone, Euridice, Castore, Alcesti. Dante scende all’inferno, dovrà attraversarlo tutto e risalire “dall’altro lato”; la patristica cristiana ha collocato la nascita di Gesù in una grotta anche se, storicamente e se mai sia stata, è un errore di traduzione oppure di una ricollocazione culturale, e probabilmente si è trattato di un caravanserraglio.
Anche Mitra nasce in una grotta, così come Eracle, e Maometto è in una grotta che riceve l’illuminazione. Nell’alchimia ermetica la discesa nelle viscere labirintiche della terra ha un ruolo centrale per la ricerca / realizzazione della pietra filosofale; l’acrostico V.I.T.R.I.O.L., formato dalle prime lettere di un celebre motto dei Rosacroce (comparso la prima volta nell’opera Azoth del 1613, dell’alchimista Basilio Valentino, espresso in lingua latina, recita: Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem, ovvero visita l’interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta. Da qui, per altri, la discesa come metafora dell’esporazione del proprio sé profondo. Della propria natura terrestre. Del proprio essere non cittadini di un labirinto, non persone alla latina quindi maschere, ma creature.

Illustrazione da “Viaggio al centro della terra”, Jules Verne, 1864.

Schema di tunnel vietcong, 1960 – 1970.
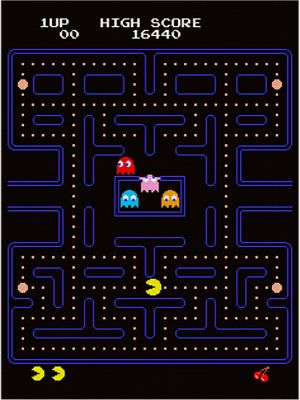
“Pacman” (Namco, 1980).

“Dungeon Master” (FTL Games per Atari ST, 1987).

“Eye of the Beholder” (Westwood Studios per MS-DOS, 1990).

Speleologo alle prese con un passaggio stretto.
La città come mostro che fagocita nelle sue viscere labirintiche, l’archetipo del labirinto di Cnosso, è un tema spesso trattato dalla letteratura e poi trasposto nel cinema. Torniamo ad indagare le origini: il campo di vista del nomade o del contadino indo-germanico, libero di spaziare fino all’orizzonte, in città è chiuso tra strutture artificiali, le architetture semplici dei palazzi proiettano linee di profondità che portano in risalto la prospettiva, quindi l’ampiezza o meno di vedute e la distanza misurabile in incroci, strade, palazzi. Non è solo un cambio di struttura visiva, ma di visione del proprio essere corpi nello spazio. Una rivoluzione tolemaico-copernicana del proprio ruolo, della propria appartenenza.

“Cabiria” di Giovanni Pastrone, 1914.

Parco dei mostri di Bomarzo, Viterbo.
Sulla base della teoria della complessità crescente, se il primo step sono stati i campi, il secondo la città, il terzo è la Rete o il Metaverso, un ulteriore cambio di visione dell’ambiente circostante che si smaterializza in dati, ma che ancora è organizzato in autostrade e nodi dagli architetti dell’informazione, ovvero: la rete informatica di ogni cloud, con i suoi sensi unici e le sue velocità di scorrimento dati. Questo è il territorio del nuovo capitalismo vettoriale, la moneta di Cnosso con la raffigurazione del labirinto diventa bitcoin. I corpi sono punti di partenza ma vicoli ciechi da un lato, server fissi in questa realtà ma aperti verso il web, hardware da cui si dipanano bit che vanno e che tornano a velocità sempre più prossime, se non superiori, a quelle neurali.

“Metropolis” di Fritz Lang, 1927. Nel futuro 2026, un gruppo di ricchi industriali governa la città di Metropolis dai loro grattacieli, e costringe al continuo lavoro la classe proletaria relegata nel sottosuolo cittadino.
Come la città necessita della sua segnaletica per regolare i flussi di corpi, così la Rete ha bisogno delle sue icone per comunicare, a corpi non più “cittadini di una sola lingua” ma provenienti – connessi – da ogni angolo del mondo, in modo pittorico, immediato, che cosa accade se si prende quel link piuttosto che quell’altro.

“Blade Runner” di Ridley Scott, 1982. I piani più alti dei palazzi sono per cittadini più abbienti, in una sorta di concretizzazione della piramide gerarchica o censoria. Più si scende verso il manto stradale, e più la popolazione diventa povera, o senza fissa dimora. Il grado zero della città del futuro, la sua pavimentazione, è perennemente immersa nell’ombra di palazzi troppo alti perché la luce del sole possa arrivare fin lì, quando non è oscurata dallo smog. Paralleli: “Gli uomini, bisognerebbe vederli dall’alto” (Jean Paul Sartre, il racconto di “Erostrato”, da “Il muro”, 1939. Il protagonista riconsidera l’importanza degli esseri umani, e in generale la necesità di essere umanitari, proprio a partire dalla figura umana vista dall’alto. Erostrato è una figura mitica dell’antica grecia, un uomo che voleva passare alla storia per aver compiuto un gesto eclatante, e che decise di dare fuoco al tempio di Artemide.

Grattacieli di Dubai, che sovrastano la struttura circolare della città, in mezzo al deserto.
Perché una città funzioni, deve imporre il suo codice esistenziale, la sua struttura gerarchica, ad albero, in contrapposizione all’esistenza biologica e interiore dei corpi che invece è rizomatica. Se i corpi si sviluppano come edere, in desideri, interessi, complessità non immediatamente quantificabili, la città labirinto offre una scelta ristretta di possibili sviluppi dei corpi-rizomi.
Lo stesso fanno le piattaforme social, di cui i corpi o le loro rappresentazioni sono utenti: ciascuna di esse cerca di produrre una quantità di possibili configurazioni e personalizzazioni per il proprio avatar online e per le sue epifanie digitali (foto, video, audio); ma a contarle, comunque, queste modalità espressive sono numerabili, finite, precostituite; l’illusione di onnipotenza nel poter gestire i propri account “come preferiamo” sono la controparte in vista di un sistema che, invece, per poter trarre profitto dall’analisi dei big-data, ha bisogno di incanalare le scelte dei suoi utenti solo in un certo numero di caselle.
Ecco le scelte del labirinto città, i bivi. I vicoli ciechi, che i corpi imputano a se stessi come errori di percorso, e che invece sono la controprova che il labirinto è finito, chiuso su se stesso; e così anche la città, e parimenti ogni piattaforma web che vuole trattenere al suo interno il maggior numero possibile di utenti, dando loro servizi perché non li cerchino altrove: stoccaggio di fotografie, video, dati in strutture che ricordano le miniere. Non a caso si parla di data-mining.

“Dark city”, Alex Proyas, 1998.

Disneyland.

Dismaland. Installazione artistica temporanea, pensata e allestita da Banksy e perdurata per trentasei giorni, dal 21 agosto al 27 settembre 2015, presso il Tropicana, un lido marittimo in disuso nella località turistica di Weston-super-Mare nel Somerset, in Inghilterra. La mostra si presentava come un “parco divertimenti anti-Disneyland” che lo stesso Banksy definì un “parco tematico non adatto ai bambini”. L’artista, oltre a finanziare la costruzione della mostra, vi contribuì con la creazione di dieci nuove opere. Furono ammessi 4.000 visitatori al giorno. Il nome dell’installazione è una parola macedonia inglese composta dai termini dismal (“tetro, lugubre”) e land (“terra”).
Quindi, chi non trova il suo posto nel ventre labirinto della città, resta sospeso, apolide nella sua stessa casa patria. I corpi sospesi spesso non vengono più chiamati “persone”, bensì “creature”, con l’accezione che se ne darà nelle righe sequenti: che siano nomadi spaesati nel Palazzo di Cnosso o nelle banlieue di Parigi, sul confine tra Messico e USA, su un gommone in mezzo al Mediterraneo tra Tripoli, Gasr Garabulli oppure Zuara, verso Lampedusa, la Sicilia oppure Malta.
1912: Eugène Atget realizza un lavoro fotografico che segna una svolta nella storia della fotografia: decide di rappresentare e raccontare i sobborghi poveri di Parigi, chiamati zone. Esseri umani dediti alla raccolta e al riuso di tutto quello che la Parigi città butta via (ma che non può nascondere nel sottosuolo), nella forma di tonnellate e tonnellate di rifiuti. Le zone sono densamente popolate, quasi quanto la città, ma sono territorio in cui vigono altre regole, diverse da quelle in vigore per le persone che abitano la città, cioè che recitano il loro ruolo nella città. Chi abita in una delle zone è lì perchè rifiutata dalla città, per povertà o diversità. In uno degli scatti di Atget, uno staccivendolo: siede su una montagna di stracci, non si vede il pavimento della baracca, a pezzi, che è il suo rifugio e la sua bottega.

2003: sull’Observer undici iracheni vengono intervistati in merito alla loro vita quotidiana, un anno dopo l’inizio della guerra USA in Iraq. Tra di loro c’è Mahdi Hussein, straccivendolo. Parla a nome di una comunità di 300 persone, che sopravvive allevando capre sulle colline di immondizia scaricate ogni giorno dai camion della città. Sono senza terra: non solo perché non possiedono alcunché, bensì anche perché letteralmente non toccano mai il suolo, né possono spostarsi alla ricerca di terra da coltivare, essendo le regole sulla proprietà della stessa a loro avverse: “siamo diventati come dei piccioni migratori senza un posto dove posarsi” afferma Mahdi.

“In questa immagine di uccelli condannati a rimanere per sempre in volo come dopo un diluvio universale senza fine è condensata la situazione di coloro a cui è stato letteralmente sottratto il suolo da sotto i piedi, condannati a restare sospesi su una terra che il pattume ha reso sterile e perciò inservibile, anche ad arrivare a toccarla con le proprie mani, sotto metri e metri di immondizie. La spazzatura della città, gli scarti di quelle merci che non avrebbero mai potuto raggiungere quando erano sugli scaffali dei negozi, sono l’unico basamento di vite che resteranno senza memoria né monumento.” (Gianluca Solla).

Bantar Gebang, la discarica di Jakarta. A causa delle sue dimensioni, viene chiamata “La montagna”.
![]()
Siem Reap, Cambogia.
Nel 1912 Rosa Luxemburg scrive per il “Die Gleichheit”, rivista bimestrale socialdemocratica pubblicata dal movimento proletario femminile in Germania. Parla di alcuni luoghi, a Berlino, che le ricordano la nave dei folli, o la galera: ma se quella dipinta da Bosch è isolata, in mezzo all’oceano, i dormitori e gli asili notturni di Berlino sono in mezzo al mare di strade che è la città, e allo stesso tempo accolgono ma isolano. Le abitanti e gli abitanti che la Luxemburg descrive sono parte di un’umanità inutilizzabile, in una società basata sulla forza-lavoro dei singoli: persone prive di valore, cioè persone prive del loro ruolo cittadino, produttivo, sociale. Perdono lo status dunque di persone. La città offre le condizioni adatte per “fare qualcosa” di quella emergenza, ma allo stesso tempo la mantiene, e la cancella, la rende invisibile. E’ una città nella città, che marca il confine tra chi ci vive dentro, e il resto delle cittadine e dei cittadini.
Secondo Roberto Esposito (cfr. “Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale”, 2007) mentre il soggetto astratto del diritto che chiamiamo “persona” si fraziona, si frammenta, per ricomporsi costantemente, trovando in questo regime di ininterrotta ricostituzione di sé la legittimazione della propria vita e dei propri gesti, per gli esseri umani indigenti a volte si usa la parola “creatura”, come soggetto nudo, forse perché è il luogo in cui ogni maschera è caduta. Sul suo volto non affiorano altre verità che le ferite che porta. Rispetto alla fragilità radicale di cui “creatura” è la parola per dirne l’incarnazione, “creatura” e “persona” rappresentano due modalità incompatibili di pensare all’esistenza.
Se “persona” è definito ogni individuo umano in quanto soggetto di diritto, “creatura” è ogni essere creato, non necessariamente autonomo, e bisognoso di protezione. L’umanesimo borghese edifica su questo discrimine la sua etica, fondata sull’autonomia morale e sulla responsabilità. Nella maschera della “persona” (e l’etimologia latina viene in soccorso) si fissa la concezione di un essere umano capace di agire autonomamente, che non soggiace alla passività; quella passività immortalata, invece, dagli scatti dei clochard fermi dove i luoghi sarebbero di passaggio, improduttivi. Lo straccivendolo seduto sulla sua pila di stracci, gli scavengers (i cercatori) sulle colline di rifiuti alle periferie delle metropoli, impegnati in azioni che non producono se non meno del loro stesso sostentamento.
Quando invece si ricorre a “persona” per garantire ai corpi oppressi la difesa dei loro diritti, non è che l’ennesima maschera dell’individualità con cui si è chiamati in causa come parti dell’ordine sociale. Lo Stato moderno si fonda sulla nozione di individuo, che permette l’ordine e la chiarezza, oltre a una distinzione effettiva di colpa e innocenza, quindi di innocenti e colpevoli. A latere del sistema di punibilità che questo ordine garantisce, è implicata la divisione delle vite, “la loro contrapposizione sempre ricomposta dalle istanze di pacificazione sociale, che dei conflitti negano l’esistenza stessa.” Implica la frammentazione delle rivendicazioni, delle esigenze, in altrettante solitudini. La sostituzione della “creatura” con la “persona” è il portato della tradizione: fa tutt’uno con la progressiva e costante cancellazione degli oppressi. Nella categoria di “creatura” si incarnano le angosce che turbano l’apparente serenità della “persona”. Hanno in ogni corpo la forma della prossimità di qualcosa di estraneo, di sconosciuto. In ogni “creatura” rimane un resto, un fondo di non-sapere che le è costitutivo.
Questo angolo in ombra è fondante dell’essere umano, nel punto di intersezione che chiamiamo essere corpi. Byung-Chul Han, ne “La società della trasparenza”, afferma che la società contemporanea è al servizio della “trasparenza”: da una parte le informazioni sulla “realtà” sembrano alla portata di tutti, dall’altra tutti sono trasparenti – cioè svelati, esposti – alla luce degli apparati che, nel mondo postcapitalista, esercitano forme di controllo sugli individui. Cosi il valore “positivo” della trasparenza maschera, sotto l’apparente accessibilità della conoscenza, il suo rovescio: la scomparsa della privacy; l’ansia di accumulare informazioni che non producono necessariamente una maggiore conoscenza, in assenza di un’adeguata interpretazione; l’illusione di poter contenere e monitorare tutto, anche grazie alla tecnologia. La società della trasparenza crea “persone” che abitino con il loro ruolo mascherato il labirinto cittadino istituzionale culturale; ma abbaglia la creatura che soggiace in loro, quella fatta di carne, di sommovimenti organici, la acceca e la immobilizza come quanto può capirne una lepre di notte in mezzo alla strada all’arrivo di un’auto in corsa.
——-
Performance.
Spostamento immobile.
Porta, benda, gasolio.
Performance, 2019.

Tempo circolare.
Bomboletta spray, ingranaggi, batterie,
scheda elettronica, cilindro su motore, foglio.
Serie: arte automatica.
Installazione, 2020.

——-
Scrivi una risposta a Tra le cose. – Roccioletti Cancella risposta